Dio è morto…
ma se Dio muore è per tre giorni e poi risorge.
La scrisse Guccini e la conoscemmo nella versione dei Nomadi. Secca, metallica la voce di Augusto Daolio penetrò nelle nostre giovani coscienze all’alba del Sessantotto. Una critica radicale del consumismo occidentale, l’esatto contrario del politicamente corretto venduto oggi da non pochi parolieri e cineasti un tempo promettenti ed oggi ridotti a camerieri dei fondi d’investimento; si sa, più che ‘l dolor poté ‘l digiuno. Fanfani aveva passato la mano a Moro, ma la lucida intelligenza costituzionale dell’Aretino, ammirata da JF Kennedy, guidava la politica estera.

Quel centro-sinistra ci diede il più straordinario benessere popolare della storia italiana, dalla nazionalizzazione dell’energia elettrica alla sanità per tutti. Molti se lo sono dimenticato, mala tempora currunt. Io ero tutto viola da diversi anni, almeno dallo scudetto perduto in dieci del 1959 contro il Milan e dissipato con la Spal di Massei, Oltramari e Morbello. La Società polisportiva Ars et Labor ed il Lanerossi Vicenza mi hanno rovinato più di una domenica e quel maledetto 26 aprile narrato magnificamente ne I Giganti della Fiorentina ha gettato nello sconforto non solo Sandro Picchi. È l’Equipe 84 però ad aver contrassegnato le mie emozioni per quella Fiorentina yé ye che sembrava destinata a riaprire il ciclo dei secondi anni cinquanta e forse lo avrebbe anche fatto almeno in parte se non fosse stata frenata con lo scudetto sul petto da una campagna acquisti inesistente, lo scambio ineguale Longoni-Mancin, catastrofica a smentire uno scriteriato ottimismo nella stagione 1970-71. Vitali, il centroavanti scomparso tragicamente pochi anni dopo, che veniva da Vicenza, un clamoroso flop e Pesaola sembrava avere smarrito la fortuna da poker del primo anno. Eppure in quell’estate del ‘67 Baglini compensò la cessione al Milan di Uccellino (non stette male solo Marianne fummo in molti a soffrire) con l’arrivo di Amarildo, Maraschi e Mancin. Quel centrocampo era formato da Bertini, Merlo e De Sisti, il vero centrocampo di México ‘70 ché senza il loro sacrificio, riguardatevi l’epico duello del mediano pratese con Uwe Seeler, Valcareggi non avrebbe potuto permettersi il lusso della staffetta tra Mazzola e Rivera. Mancava per il mio inestinguibile rammarico Claudio Merlo che pagò forse la poco brillante amichevole del 5 gennaio 1969 a Città del Messico, e non mi sembra che quel ruolo, salvo alcuni spunti di classe eccelsa di Rivera ma, ne sono sempre più convinto, absit iniuria verbis, il goal alla Germania fu mero culo su passaggio dell’immenso Bonimba, sia stato coperto bene. Quando poi nella finale giuocata alla pari col Brasile per 60 minuti la stanchezza cominciò a pesare anche sul superbo Domenghini, il crollo fu inevitabile. Insomma per tornare al grande Nello Baglini quella squadra che aveva vinto lo scudetto non fu rafforzata per niente ed il rinnovamento dell’anno dopo ci stava per costare carissimo. Calcio mistero senza fine bello, canta, parafrasando Gozzano, Francesco Salvi, ineguagliabile aedo prescelto da Eupalla, e così risparmiamo ai lettori inutili analisi sull’arbitraggio del gigantesco Concetto Lo Bello.

Duce Duce lo gratificò irridente il popolo viola almeno in due occasioni, questa e nel gennaio ‘61 con l’Inter, in casa col Cagliari alla quinta del 1969-70 oppure con la Juventus a Torino, quando giuocammo molto meglio dell’11 maggio precedente. Al tempo del potere arbitrario ed invisibile del VAR apprezzo come non mai Lo Bello che aveva il pregio di sostenere le sue decisioni con autorevolezza, da capo vero sfidando fisicamente, se necessario, senza timore pubblico e giuocatori, un protagonista assoluto del nostro football. Avenne oggi. Ché forse il Sor Nello, “gli occhi furbi gli illuminan di riso lo strano viso” come il Gianni Schicchi di Puccini e Forzano, si era accorto già allora che la geopolitica non ci consentiva di andare oltre proprio in virtù di quella trasformazione delle società in SpA, che per loro natura esaltano le capacità finanziarie ed il bacino di clienti e di conseguenza aumentano i dislivelli competitivi. Ma allora perché quell’acquisto di Vitali, 600-700 milioni mi pare contro i 400 della vendita di Bertini solo due anni prima? Si torna all’aforisma Gozzano-Salvi a cui aggiungo il “fattore umano” di Graham Greene, che sembrano fatti apposta per esaltare quell’imprevedibilità unica che ci tiene incollati al vero primo amore della nostra vita.

Pubblicità e diritti televisivi a distanza di cinquant’anni inevitabilmente dopano il mercato e chi ci rimette è il calcio di provincia e quello minore che non possono reggere su questo piano. I fondi d’investimento la fanno da padroni e richiedono una redditività sempre maggiore basata su un modello di entertainment che desacralizza “la domenica della buona gente”, per citare un film esemplare del 1953 niente po’ po’ di meno che di Anton Giulio Majano, il regista dei nostri polpettoni classici della somma TV educatrice di Bernabei, la spalma sull’intero spazio settimanale, spezzetta lo spettacolo calcistico secondo Tik Tok o Instagram, riprogramma il tifoso via smartphone in un follower cyber friend non più in grado di inseguire mitologicamente per il viale dei Mille Desolati e Speggiorin.
Ora bisogna intenderci: il football, suprema passione della nostra vita, è sempre stato softpower, non è una novità. Nato nei collegi dell’upper class albionica diventa presto divertimento di massa della matura rivoluzione industriale, c’è una discreta serie su Netflix, The English Game, che al di là del romanticismo inevitabilmente melenso ma accattivante in chiave old style, innesta la sua crescente popolarità sul tronco delle lotte di classe di fine XIX secolo. Di lì a poco diventerà il modello, come altri costumi ed abitudini sociali, per la sua espansione nel Belpaese, unificato da Cavour e Garibaldi sotto il manto protettore di Lord Palmerston, del non expedit di Papa Leone XIII, un’Italia ancora non segnata dalla nascita del Partito Popolare Italiano del 1919 e del Concordato del 1929. I colori delle maglie e le stesse denominazioni come Milan e Genoa si rifanno direttamente alla lingua inglese.
E così arriviamo al primo dopoguerra. È infatti col fascismo, che ci piaccia o meno, che il calcio diventa pienamente strumento di creazione del consenso e di persuasione, e se la cinematografia rimane l’arma più forte, non c’è dubbio che il calcio fa passi da gigante. Due mondiali e un’olimpiade, mica seghe si sarebbe detto da ragazzi. Alé Fiorentina, a partire dall’ancestrale Alfredo Manoelli all’amico di quasi una vita Fabio Fallai, con il contributo di Filippo Luti, ha scritto pagine miliari sulla nascita ed i primi campionati della Fiorentina, sul suo rapporto con la città, sul successo del football come divertimento popolare capace di coniugare l’identità civica italica, i tanti centri urbani di una storia millenaria, con le ambizioni del regime a cavallo delle due guerre, la guerra civile europea 1914-45 secondo la definizione di Ernst Nolte.
Nel secondo dopoguerra, come già detto, ha accompagnato i sogni della buona gente pervasa dall’ottimismo della volontà di una ricostruzione che ci ha portato a diventare alla fine degli ottanta la quarta potenza economica mondiale. Un miracolo economico e sociale che ha innervato lo stesso calcio, dopo l’onta dell’eliminazione al primo turno del 1954, al mio babbo educato nel mito dei ragazzi della via Pál ed innamorato di Hidegkuti, caro Marco (Pieri), quella sconfitta magiara non lo convinceva proprio, e della mancata qualificazione 1958 in Svezia, quest’ultima comunque ci regalò il più grande goleador della nostra storia, Kurt Hamrin, la gamba tesa di Ken Aston a Santiago del Cile il 2 giugno 1962 e la mescolanza di ingenuità e di sfortuna del 1966 a Middlesbrough dell’ottimo Mondino Fabbri che andava in vacanza a Castelbolognese, merita un film di Pupi Avati.
L’Inter di Angelo Moratti ed il Milan di Gianni Rivera ai vertici mondiali, alla Juve non bastano l’Avvocato e Pamela Churchill, Artemio Franchi e l’Europeo del Sessantotto a Roma ed il secondo posto a Città del Messico che poteva essere primo della nazionale più forte di sempre dietro ai carioca più maturi, non più forti in assoluto, di sempre, consacrano la ritrovata grandezza dell’Italia che verrà ribadita nell’Argentina 1978 del Flaco e dei desaparecidos e nel trionfo euro-socialista di Madrid 1982. È un calcio ricco e pervasivo, inarrivabile per gli altri sport-spettacolo, muove le passioni e le gambe di milioni di italiani, riempie i palinsesti radiofonici e televisivi, costringe i politici, e che politici, a dichiararsi, tanto per dire Andreotti romanista e Craxi per il Torino non ne dubitavamo, Pertini si fa monumento nazionale l’11 luglio 1982 al Santiago Bernabéu prima e più che ai funerali di Enrico Berlinguer. Ed arrivano Falcao, Platini, Zico, Passarella, Maradona a far felice Napoli e tanti altri primi attori, di qualcuno che non nomino noi tifosi viola avremmo fatto volentieri a meno. Per inciso anche questa volta non riusciamo a dare solidità al salto di qualità che la Fiorentina per la verità prova a fare. Non ce lo fece fare, allora eravamo i più forti in Italia e lo saremmo rimasti fino al ‘60 secondo gli stessi giuocatori viola, l’olandese Leo Horn, dando alla squadra di Di Stefano un rigore per un fallo palesamente fuori area, nella prima finale di Coppa dei Campioni del 30 maggio 1957. La tegola che si abbattè su Montuori a nemmeno 29 anni chiude quel ciclo. Ci risolleviamo intelligentemente dalla paura del ‘71 che veniamo asfaltati dal tir dei gravi infortuni di Roggi e Desolati e dell’incidente irrimediabile a Guerini dell’autunno 1975, era quella una Fiorentina forte con molti giovani già nazionali che aveva appena vinto la Coppa Italia; e del resto Casarsa e Speggiorin, che non erano nemmeno i più quotati, faranno la fortuna del Perugia di Castagner, così come Di Gennaro, Bruni e Sacchetti saranno determinanti nel Verona di Bagnoli.
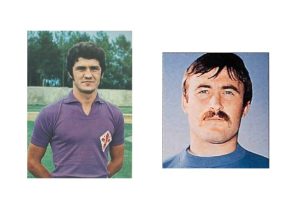 Del doppio infortunio ad Antognoni nel momento della massima maturità calcistica e della posizione in campionato si è detto apparentemente tutto, ma poco a mio avviso sulla sua dinamica decisiva ai fini di ambedue i mancati scudetti. Per finire con il ginocchio di Batistuta che ci pregiudica la vittoria nel 1998 e così via fino a Mario Gomez ed a Giuseppe Rossi. Non conosco altre squadre di fascia alta che possano vantare una serie di disgrazie così mirate a troncarne le ambizioni nei momenti topici della loro Storia. È vero quello che ci dice Woody Allen in Match Point che occorre più fortuna che talento, mettiamola così.
Del doppio infortunio ad Antognoni nel momento della massima maturità calcistica e della posizione in campionato si è detto apparentemente tutto, ma poco a mio avviso sulla sua dinamica decisiva ai fini di ambedue i mancati scudetti. Per finire con il ginocchio di Batistuta che ci pregiudica la vittoria nel 1998 e così via fino a Mario Gomez ed a Giuseppe Rossi. Non conosco altre squadre di fascia alta che possano vantare una serie di disgrazie così mirate a troncarne le ambizioni nei momenti topici della loro Storia. È vero quello che ci dice Woody Allen in Match Point che occorre più fortuna che talento, mettiamola così.
È questo il cruccio che alimenta la leggenda viola, quella del perdente di successo, non a caso il titolo della bella autobiografia di Giorgio Albertazzi, che tifoso della Fiorentina lo era davvero come Zeffirelli, un amore che era carne e spirito della città. È il mio Calcio che non c’è più perché quel mondo identitario, industriale e rappresentativo di una dialettica sociale superata non esiste più. Insieme al Muro di Berlino ed alle ideologie, marxismo e liberalismo ma anche le religioni rivelate non se la passano bene, nell’89 sono rovinati due secoli, il XIX ed il XX, e nel XXI l’unipolarismo americano e la globalizzazione ufficializzata con l’entrata della Cina nel WTO, la World Trade Organization, hanno prodotto un multipolarismo ferocemente competitivo, in cui cibernetica e controllo sociale vanno a braccetto, per sintetizzare il quadro senza rischiare di pasticciare ed offendere qualcuno. La definizione di capitalismo politico, amici miei, è harvardiana e Shoshana Zuboff, Il Capitalismo della Sorveglianza, è pubblicata negli Stati Uniti d’America da Public Affairs 2019 ed in Italia dalla Luiss. La sentenza Bosman ne fu una logica consequenziale declinazione, il mercatismo squarciava il protezionismo calcistico, spaccava il controllo sulla forza lavoro senza, fateci caso, bisogno dell’Associazione dei calciatori alla maniera corporativa e lo stesso mitico avvocato Campana andava in soffitta, insieme al modello economico misto pubblico-privato che dagli anni trenta governava il Paese. E così la vecchia Eupalla del Guerin Sportivo con le sue figurine tributarie dei gonfaloni e della rivalità della provincia italiana e della Liebig, ha ceduto il passo agli highlights da smartphone e si è trasfigurata in un Dio non binario che si invera secondo le forme ed i codici dell’entertainment. Che non ammette recite a soggetto, solo qualche variante del canovaccio ed è uno e bino con l’Algoritmo del Var.
Questo è il mondo in cui deve navigare Commisso, l’ecosistema in cui opera il management viola, molto oltre la complessità delle relazioni con la burocrazia politica ed i nostri posti tramandati allo stadio tra Comune e vivaticket. E non mi pare che Rocco se la cavi male, tutt’altro, considerato il blasone millantato, talvolta ingenuamente, della nostra città diventato negli ultimi trent’anni inversamente proporzionale al suo peso reale. Il delirio woke delle Olimpiadi occidentali di Parigi punta ad accelerare il passaggio al metaverso sportivo di cui il Calcio rimane l’obbiettivo principale ed anche, per nostra fortuna e per sua natura, il più resiliente, è un termine che va di moda ma ci sta, alla trasfigurazione da grande passione popolare identitaria a mero spettacolo globalista predeterminato dalla “confluenza sociale, nella quale la pressione del gruppo e la certezza computazionale sostituiscono politica e democrazia” (Shoshana Zuboff), annullando il cuore della competizione sportiva. Cioè la possibilità reale che il Catanzaro, come nella finale di Coppa Italia del 1966, possa battere la Fiorentina e chissà che non ci sarebbe riuscito senza la mano suicida di Sardei e l’esito fortunato per noi del rocambolesco doppio palo interno del rigore di Mario Bertini. Evento indimenticabile per i catanzaresi e per me, uscito traumatizzato da quella frazione di secondo, alla base, credo, del gemellaggio che ci unisce.

Mi fermo qui sennò alla fine il Fallai è costretto dalla “confluenza sociale” a censurarmi.
Voglio soltanto dire ai miei vecchi tifosi viola che amo e che si sono sbattuti ad Atene contro ta pediá tou Pireá della Dea vera, Melina Mercouri, di essere indulgenti, io per primo ovviamente, perchè l’intreccio tra Finanza e Geopolitica ha reso veramente grande e terribile il mondo del calcio. Con i grandi eroi del passato, Uccellino mi si è impressionato indelebilmente, se n’è andata definitivamente la magia dei transistor a cui stavamo attaccati la domenica pomeriggio per poi passare al tempo trasmesso alle sette e un quarto dalla televisione ed a quell’altro, quando partì il secondo canale, dopo le 22, ai filmati della domenica notte prima dell’avvento della Domenica Sportiva, ai quotidiani divorati il lunedì se non si era già presa a mezzanotte La Nazione appena uscita fuori della nostra meravigliosa stazione di SM Novella, questa sì a ragione di Firenze vanto e gloria, oppure addirittura più fresca di rotativa all’uscita dei furgoni addetti alla distribuzione, come a carpirne l’anima, ma solo quando la Fiorentina aveva vinto in trasferta, per poi mangiare talvolta un piatto di tortellini dai Fratellini Briganti in piazza Giorgini non ancora assurti a cotanta fama.
E se non ci dobbiamo vergognare della nostalgia che origina dalla diffidenza nei confronti del futuro, al tempo stesso non possiamo sottrarci a cogliere la sfida del presente, il digitale lo è e di riffa o di raffa non possiamo scansarlo. Va trasformato in un valore aggiunto, operazione tutt’altro che facile ma d’obbligo per continuare a vivere una passione che è connaturata al dna, facendone strumento per rilanciare il Calcio sulla base del sentimento di appartenenza. Dobbiamo farlo sfidando un uso sapiente delle applicazioni informatiche che mettono in comunicazione le persone che sono tifosi e sportivi, giovani ed anziani, genitori ed utenti, clienti-consumatori e soggetti di diritti, individui e famiglia, borgo e forma urbana, spettacolo e amore. Lo smartphone non è solo percezione ed immediatezza, persuasione occulta anche quando è palese, induzione e soddisfazione dei desideri interiori, sfogo e gregge, può diventare conoscenza e comunità, rete di una nuova ecologia civica, farsi popolo ed aiuto reciproco, innovazione e manutenzione della Tradizione, culto degli avi e prospettiva per le nuove generazioni, non necessariamente il braccio armato del Grande Fratello a cui arrenderci.
Ci ritorneremo inevitabilmente sopra cercando di indicare una strada concreta, praticabile. Intanto entriamo nell’ordine di idee che vale la pena provarci e la gloriosa storia dei viola club ormai sessantennale è la piattaforma ideale per contribuire alla rifondazione digitale, beninteso guidata, di un football che valorizzi le proprie radici e non affoghi nello stagno dello spettacolo-business, sempre più software televisivo e sempre meno processo di crescita umana e sociale.

Bisogna vedere oltre l’orizzonte che il guardo esclude, ci insegna il Poeta. La Storia, grazie a Dio, non finisce mai, nonostante a noi troppo spesso comprensibilmente sembri racchiusa nel breve spazio di una vita, la nostra. Contro la logica illuminista del solo ciò che è reale e razionale, noi siamo sempre più convinti di quanto si legge in Giovanni 29.20, “beati coloro che non hanno visto ed hanno creduto”.
Gianni Bonini – Viola Club Franco Nannotti




